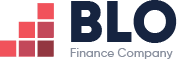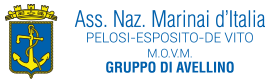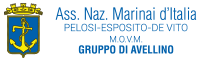Arturo VIETRI nacque ad Avellino il 16 ottobre 1894 da Michele e Carolina BASILE. Arruolato nella Regia Marina partecipò alla Scuola Sommergibilisti al termine della quale partecipò alla guerra italo-turca negli anni 1911-12. Pochi anni dopo , con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale , il sommergibilista Arturo VIETRI si trovò imbarcato sul Sommergibile “JALEA” che operava nelle acque della laguna veneta.
La tragedia, una delle tante che segnarono il grande conflitto mondiale, si consumò nel pomeriggio del 17 agosto 1915, nelle acque del golfo di Trieste. Il sommergibile “JALEA”, partito da Venezia il 16 agosto, nel corso della sua ottava missione in mare ed in navigazione di rientro alla base, urtava contro una mina di sbarramento nemico affondando a circa tre miglia a est sud-est del banco di sabbie di Mula di Muggia, di fronte alla pineta di Grado.
Unico superstite e testimone della tragedia dello “JALEA” fu il sottocapo torpediniere silurista Arturo VIETRI. Egli aveva subito raccontato il repentino affondamento del sommergibile davanti alla all’apposita Commissione , istituita immediatamente presso il Comando Marina di Venezia.[1]
Più tardi lo stesso racconto fu ripreso da Cesco Tomaselli e Pubblicato da A. Mondadori nel 1937 nel libro “ Le avventure Eroiche” , con il titolo “La nuotataccia”.
Questo è il racconto dell’odissea del naufrago VIETRI:
Un sommergibile nazionale s’è immerso all’altezza di Grado or son vent’anni, il 17 agosto 1915, giusto sul far del giorno. Non è più risalito a galla.
Ecco i drammi che a tanta distanza afferrano ancora alla gola. Il sommergibile sarà sempre, per noi, gente di superficie, un natante diabolico, uno strumento che parla più all’immaginazione che ai sensi, una cosa da star a paro con gli squali e coi giganti degli abissi marini.
Intorno a un uomo che frequenta l’interno di questi mostri ci dovrebbe essere tanta riverenza come intorno agli eroi dei poemi nazionali: ma nella vita di ogni giorno chi li conosce ?
Sono esseri vestiti alla marinaia come tanti altri: esseri però che, quando fanno parlar di se, o è per corazzate che ribaltano con la chiglia in su, o per convogli di navi che in cinque minuti cancellano dall’orizzonte, o per casi come questo che ci accingiamo a raccontare.
Il meriggio di quel giorno che è stato visto immergersi dal semaforo di Grado, il JALEA naviga a quota di periscopio, dopo aver posato sul fondo dal mezzogiorno alla una per la colazione degli uomini. Il sommergibile, con a bordo il comandante Giovannini e ventitré persone (in realtà ne risultano 20) fra stato maggiore ed equipaggio, è uscito da Venezia la sera precedente con la consegna di passare a nord degli sbarramenti in prossimità della costa, proseguire in emersione verso Grado e al far del giorno immergersi per dislocarsi nel golfo di Trieste, regolandosi in modo da raggiungere Porto Buso verso il tramonto, oppure posarsi sul fondo tutta la notte.
Sono le 14:50 del 17 agosto. Il torpediniere silurista Arturo Vietri, di Avellino, che mezz’ora prima è smontato di guardia al periscopio, si è ritirato nei locali dei tubi di lancio di prora, e di là rammenta di aver udito il comandante ordinare al marinaio di guardia ai timoni : ” Vieni per 152 “.
Subito è iniziata l’accostata per invertire la rotta. In quell’istante è da porsi il disastro.
Ora sappiamo che il JALEA è andato a urtare contro un banco di mine austriache di recente collocato al largo di Grado: ma a bordo non è avanzato tempo di formulare ipotesi che la catastrofe è precipitata addosso a quegli uomini come la valanga in montagna.
Nella repentina oscurità che incomincia a puzzar di cloro, qualcuno di prora ha gridato: ” Acqua “.
Quasi di rimando risuona l’ordine del comandante: ” Aria a tutto ! “.
Sono le uniche parole del dramma. La lancetta del manometro si sposta velocissima; sei metri, otto, undici, tredici, quattordici, e qui si ferma….Tutti hanno avvertito un tonfo, il senso di aver finito di cadere, di aver toccato il fondo della propria tomba.
Buio, acqua che irrompe gorgogliando, odore di cloro, silenzio: qualcuno già non respira più.
Ma sei uomini si dibattono nella luce violacea della torretta.
Si, figliuoli, quella è forse l’unica via di scampo. Ma chi ce la fa a sollevare il portello di bronzo, spesso 450 millimetri, con quattordici metri d’acqua sopra ?
Coraggio, ragazzi, spendete l’ultima oncia di fiato, che avete ancora due dita d’aria sopra la testa, due dita che valgono cento braccia……..Forza, ora viene…….Chi l’ha aperto ? Pare sia stato il maresciallo Armellino, che ci si è messo con tutti i suoi muscoli. Saltato il portello, egli è stato visto partire come un tappo. Ma gli altri gli sono guizzati dietro a distanza di secondi.
A galla si ritrovano: sono sei in cerchio, uno di fronte all’altro, in mezzo a larghe chiazze di nafta, già quasi irriconoscibili per lo sbilancio di pressione e per i veleni respirati. Chi è quello che sanguina dalla fronte ? E’ il tenente di vascello Cavalieri. Soffre forse più di tutti. Vietri gli si avvicina e lo aiuta a togliersi la scarpe e i pantaloni. Lo stesso fanno il sottocapo Di Biagio, l’elettricista Motolese, il marinaio Giacometti: solo il maresciallo Armellino, che è stato schizzato a galla col berretto in testa, si terrà addosso ogni cosa. E ora che fare ? Non è difficile arguire quale possa essere il programma di bagnanti in quelle condizioni: cercar di agguantare la più prossima terra. E si direbbe anche abbastanza vicina: a Punta Salvore, per esempio, pare di poterci arrivar con quattro bracciate. Ma quegli uomini sono dei marinai italiani: quantunque lunga sia la via verso la costa friulana, quella essi tenteranno, che ogni altra significa nuotare verso la prigionia.
Il dramma si sviluppa secondo ordini di fatalità: diciotto giacciono in fondo al mare, cinque malediranno di aver rivisto il sole per essere così orrendamente giocati dalla sorte; uno solo, il più robusto, il più calmo o il più disperato, vedrà spuntare il nuovo giorno. Così è. In presenza del destino, altro non siamo che foglie turbinate dal vento: non si sa mai l’attimo in cui la raffica ci poserà, e dove, e se per sempre.
Incominciamo a nuotare. Il mare è leggermente increspato, l’aria calda, pesante. La costa di Grado, perché bassa, non si scorge a fior d’acqua. Per un po’ rimangono in gruppo, poi uno si ferma, e un secondo, e un terzo. Fermarsi vuol dire non aver più forza per proseguire, darsi vinto per lo sfinimento o per il crampo.
A mano a mano che affogano, gli altri odono un grido, o un appello, o un’invocazione.
Ora è la volta del maresciallo Armellino. ” Vietri, figlio mio, aiutami, non ne posso più……” ” Ma faccia come me, maresciallo, si spogli: ora vengo ” Vietri tralascia di svestire Motolese e va verso l’altro. ” Maresciallo, si dia forza…..” Ma egli ormai nuota verso un berretto che galleggia. E quattro.
Il sole declina, l’aria rinfresca, è triste veder sopraggiungere la sera quando si è naufraghi in mezzo al mare.
Motolese sta zitto per quindici o venti metri, poi gli torna l’avvilimento. Che pena non poter soccorrere l’amico come il cuore vorrebbe……..Bisogna su col morale, mostrargli come ci si riposa, che in quelle condizioni il pericolante è fuori di senno, si attacca alle spalle, il che è come dire affogare in due. E sono amici.
” Arturo, dammi la mano. Vado giù. ” La voce è ormai di un uomo che supplica, allo stremo delle forze.
” Ebbene, finiremo insieme “, pensa Vietri: e nuota verso il compagno, che una cresta d’onda gli nasconde.
Ma anche dopo non vede più nulla. Come è nemico degli amici il mare……Certo egli è andato sotto quando ha gridato: “Arturo, dammi la mano “. Forse non voleva nemmeno esser soccorso: gli bastava veder il volto dell’amico nel momento di abbandonarsi.
Ora Vietri è solo. Cerca di raccapezzarsi. Ecco: con uno sforzo potrebbe raggiungere prima di notte la Mula di Muggia, a oriente di Grado. Ma dove sono esattamente gli austriaci ? No: nel dubbio è meglio continuare al largo, puntando verso Grado o la Bassa Friulana. Scende la notte, scura, nuvolosa, con chiarori strani all’orizzonte. Sono i razzi del Carso, è la solita pirotecnica di tutte le notti, ma è insolito vederla così, dal largo, a pelo d’acqua. Ora guizzano vampe sanguigne: ha da essere un bombardamento sul San Michele. Si distinguono i tonfi dei grossi calibri : bo-ouòm, bo-ouòm……Poveri soldati, neanche loro se ne vedranno il sole domani…….Non si può dire quale sorte sia più precaria: essi sotto le granate dirompenti, la sassaiola delle pallette di piombo, la falciata delle mitragliere, egli evaso da una tomba, sperduto in quel mare nero, con l’acqua sempre alla gola e il crampo che se gli prende la braccia è come una pallottola alla spina dorsale. Ogni tanto gli si raffredda la spalla sinistra. Deve allor cambiare posizione, e nuotare immerso da quella parte. Nuota economicamente, cercando di risparmiare le forze per quando tornerà il giorno.
Non ha ancor vinto il ribrezzo della notte, dell’acqua nera: quando scopre che, agitandola, anche quell’acqua color inchiostro diventa chiara e fosforescente, vien preso da una contentezza puerile.
D’un tratto ha un sussulto. Ha urtato contro qualcosa di viscido e di tentacolare, per cui ha dato un balzo indietro. Il primo pensiero è stato di aver “sentito” qualcuno dei suoi poveri compagni…….Cinque minuti dopo, riavendo lo stesso contatto, riderà della precedente paura: ma non sarà abbastanza avveduto da realizzare che un banco d’alghe rappresenta, per un naufrago in quelle condizioni, un’illusione d’appoggio che ha la sua influenza sul morale. Le tre di notte. L’ora dei capolavori e dei delitti, delle sentinelle che s’addormentano e dei colpi di mano. Sulle linee è tornata la quiete. Il cannone tace. Qualche razzo zampilla ancora sulle quote dove infuriò il bombardamento. Altrove la guerra sonnecchia.
Animo, Vietri, se superi l’alba sei salvo…….Di solito, all’alba, i vecchi muoiono, ma chi vuol conquistarsi il mondo comincia col sole la sua giornata. Tre anni più tardi, nella semi luce di un’alba Luigi Rizzo affonderà una corazzata di linea.
Non nuota quasi più. Le forze lo stanno abbandonando. Gli sopraggiunge quella sonnolenza invincibile ch’è il preludio dell’estremo abbandono, quasi una forma di soave agonia. Strani pesi gli stirano le braccia e le gambe, dalle stremità intirizzite guizzano lunghi brividi, ha la sensazione che gli lavino la schiena con un acqua gelata. ” Ora mi lascio……..” mormora a se stesso. Rivede a uno a uno i volti dei cari compagni, che da parecchie ore hanno finito di penare. Riode le parole del comandante Giovannini, che poteva tentare anche lui di salvarsi e ha preferito restare dentro la nave spezzata, insieme con gli uomini che non avevano scampo.
” Andate……io resto qui……per me è finita ” Qualcuno aveva giusto vent’anni. Già, ma anche lui è di quel giro, è della classe 1894, ha ventun anni. Come si fa a morire a ventun anni, come si fa a dire addio alla vita proprio nel momento in cui si schiude ?
Qui bisogna inventare qualcosa per rimettere in circolazione il sangue, per riscaldare i muscoli, per vincere la sonnolenza. Gli viene una pensata: canterà. Non ha mai cantato nella sua vita in quelle condizioni, pochissimi uomini devono esserci al mondo che possano dire di aver fatto altrettanto. Eppure è vero che fa bene cantare: tanto vero che il giorno è spuntato ch’egli quasi non se n’è accorto. Improvvisamente ha avvertito come una carezza calda sulla nuca, e nel medesimo istante gli è brillata dinanzi agli occhi la punta del campanile di Grado. La salvezza imminente gli ridesta tutte le energie. A trecento metri dalla riva incomincia a chiamare; poi scorge una boa e si dirige a quella, sospirando di potersi attaccare al gavitello e non arriva che a graffiarlo.
Solo al quarto tentativo lo agguanta.
La felicità di aggrapparsi a un corpo solido gli fa quasi perdere i sensi. Per alcuni minuti rimane avvinghiato a quel cono galleggiante, le unghie conficcate nel minio, il sangue inerte, gli occhi chiusi. Come in un dormiveglia ode un megafono che parla dalla riva, poi delle voci vicine che gli fanno alzare la testa; un ” topo ” vogato da marinai avanza nella sua direzione. ” Chi sei ? “, gli gridano dalla barca, ” JALEA “, risponde.
” Il sommergibile affondato ieri ?….. ” ” Si “.
Qualche minuto dopo una piccola folla di soldati e di marinai fa largo sulla banchina a un uomo completamente nudo, che respinge la barella e chiede soltanto una sigaretta, perché vuol mostrare che una nuotata di sedici ore non manda all’infermeria un marinaio italiano.
” Acqua, datemi acqua ! “. Ha una sete da commettere un omicidio. Al corpo di guardia un marinaio crede di far bene offrendogli un cognac; egli scaraventa a terra il bicchierino, che il primo impulso era di tirare in faccia all’imprudente. ” Del cognac a uno che muore di sete…….” Non osano più contrariarlo. Lo lasciano ingoiare una dopo l’altra due bottiglie. Ora è calmo, si stropiccia gli occhi, sorride. Che tremenda avventura…..Non gli par vero di esser lì a raccontarla. E deve raccontarla ai superiori, deve raccontarla a Sua Maestà il Re,” che volle facesse subito un telegramma a mamma mia, che allora aveva quattro figli sotto le armi “, deve ripeterla a tutti quelli che gli regalano una sigaretta, un pettine, un biscotto, pur di farlo parlare.
E’ felice. Gli hanno promesso la medaglia d’argento.
Il capitano di vascello Bonelli, comandante della flottiglia sommergibili, se lo conduce a Venezia n macchina scoperta; egli indossa un uniforme senza stellette e tiene dei giornali sul petto. A Mestre, in un ristorante pieno di ufficiali, tutti commentano il suo aspetto, tutti lo guardano, però nessuno commette l’indiscrezione di domandargli chi sia. Se un Capitano di Vascello se lo porta dietro in quello stato, ci sarà la sua ragione.
E’ trasognato. Gli par sempre di nuotare. Così suppone che debbano camminare i sonnambuli sugli spigoli dei tetti. Ed ecco che viene la sera, ed egli ritorna sulla nave-appoggio dei sommergibili, come se tutta quella storia fosse stata realmente un’allucinazione.
E’ già suonato il silenzio. Egli va diretto al suo quadrato, senza pensare a nulla, desideroso soltanto di buttarsi su un letto. Sopra la solita porta legge : ” JALEA “. Si affaccia, e vede una cosa che doveva pure immaginare, s’avesse un po’ riflettuto: vede i posti vuoti, le brande fatte a sacco, le plance senza cassette.
Nessuno di quelli che hanno ancora il nome nella targhetta riposerà più su quelle brande.
Questa volta non riesce più a dominarsi; gli viene un pianto convulso che dura qualche minuto. Poi automaticamente, scioglierà la catenella della branda su cui è scritto ” Vietri Arturo, matricola 39.120 “, si tirerà la coperta sulla faccia e proverà a dormire. FINE
I ricordi di Vietri arricchiscono di particolari il racconto di Tomaselli fermando l’attenzione ai sei naufraghi, che più tardi si scoprirà essere stati in verità sette, dovendosi tenere conto, con Vietri, Cavalieri, Di Biagio, Giacometti, Motolese e Armellino, anche del secondo capo torpediniere Giuseppe Martignoni di Secondigliano, che ripescato morto sarà il primo ad essere tumulato a Redipuglia.
Della “Grande Storia” ne ha parlato per primo Gabriele D’Annunzio, il 20 settembre 1916, in un articolo dal titolo “I morti del mare” finito in prima pagina del Corriere della Sera.
Il primo volo di ricognizione, infatti, finalizzato alla localizzazione del relitto dello “Jalea”, era stato organizzato il 27 agosto 1915 dallo stesso D’Annunzio a bordo di un “Albatros” pilotato da Giuseppe Miraglia, la stessa coppia che il 9 agosto 1918 compirà il famoso volo Vienna. D’Annunzio ne parla più approfonditamente anche in una “Licenza” aggiunta all’edizione della “La Leda senza cigno” del 1916. Con il suo inconfondibile stile ci descrive i sei marinai che riuscirono ad uscire dal relitto appena questo toccò il fondo del mare e il ritrovamento di Arturo Vietri, l’unico superstite.[2]
“Questo dramma sottomarino è d’una brevità e d′una novità non eguagliate da alcun’altra delle tragedie navali conosciute. Le persone del dramma sono vestite d’acqua sino al collo. I corpi sono già ingoiati dall’abisso; ma le sei maschere umane respirano ancora allo stesso livello, nell’aria che comprime la massa irrompente e le impedisce di invadere tutto lo spazio chiuso. La mia immaginazione vede quei sei respiranti teschi decapitati dal filo dell’acqua, e non riesce a rilevare i loro lineamenti né a rischiararli di quel chiarore incognito. Li cerco invano nel tranquillo occhio nero del superstite che forse ne serba l’immagine ma non l’esprime. Non so che avida violenza è nel mio sguardo, come per sforzare quel taciturno a rievocare il momento indicibile, come per comunicare l’acuità dei miei sensi a quel sobrio narratore.
Che accadde quando il portello di prua fu aperto e il primo uomo balzò fuori e gli altri lo seguirono risalendo dal profondo verso la luce che a mano a mano cresceva? Vietri fu l’ultimo ad abbandonare lo scafo squarciato. La vita non v’era del tutto spenta. Pochi attimi innanzi, il comandante era stato intraveduto ancora in piedi. Il resto dell’equipaggio non aveva dato grido né segno, ma forse laggiù nella tenebra qualche gola palpitava tuttavia.
E v’era tuttavia l’ultimo dolore delle cose, l’aspetto estremo delle cose che non hanno più potere, che non servono più, che non indicano più nulla, che non misurano più nulla: il portavoce, il tubo del periscopio, i cinque tubi della pompa, i tre segnali rossi, la lampadina della bussola, i quadranti degli indicatori, le ruote dei timoni, la bandiera avvolta… Il manometro grande aveva segnato i metri di profondità? aveva misurato di metro in metro la discesa del sepolcro? V’era là, in quegli ultimi attimi, un odore, un rumore, un silenzio, un’ombra, una figura finale, una faccia della sorte, un estremità immaginabile che questi giovani occhi videro e che nessun altro mai vide né vedrà mai. La poesia in me trema e si vela.
Ora le cinque teste umane, l’una dopo l’altra, emergono a fiore del mare deserto. Si contano. Una chiazza oleosa li ha preceduti. Ecco Vietri a galla: respira; si netta il viso con una mano; sente nel torace i suoi polmoni e il suo cuore; sente sotto il cranio il suo cervello maschio. Tutto in lui è sano e pronto. Subito le sue forze si equilibrano, la sua mente s’aguzza, la sua bontà si offre. E tutto il suo coraggio si quadra nella disciplina. Aiuta Guido Cavalieri a togliersi le scarpe e gli accomoda il materasso di gomma (ve n’erano otto a bordo) che gli serve a meglio sostenersi.
Dà una mano agli altri per liberarli dagli impedimenti. Sveste il torpediniere Motolese, che pare il men vigoroso. Poi pensa a sé medesimo. Sa che non ha grand′arte nel nuoto e che gli conviene adoperare ogni accorgimento per risparmiarsi. Il mare è mosso da scirocco. Quando egli s’allontana dal luogo del naufragio, dove pullula la nafta mista alle bolle d’aria, quasi rantolo e sangue della nave uccisa, un gran dolore gli fende il petto. Fa tre volte il segno della croce, raccomanda a Dio le anime dei sepolti, promette di recare il messaggio alla patria. Poco dopo, ode dietro di sé il grido soffocato del torpediniere che già pericola; ode l’utima voce di Ciro che annega; vede davanti a sé il gruppo degli altri tre nuotare più veloce verso ponente. Rimane solo. Il mare è sempre deserto.
Lo scirocco rinfresca. Sul far della sera, dopo circa sei ore di nuoto, il naufrago avvista la Mula di Muggia, ha l′illusione della salvezza, la tentazione dell’approdo. Ecco il momento eroico di questo gran cuore marino. La terra è là, sinuosa e bassa, coi suoi lunghi dossi violacei. La sera sinistra cala su la solitudine non interrotta né da una scia né da una traccia di fumo. Lungo la costa nemica si accendono i fasci di luce che scrutano il cielo e il mare ostili. Dai cannoni che tuonano su l′Isonzo, si propaga il rombo per tutto il golfo. Nessuna stella sgorga dal crepuscolo che s’abbuia. Laggiù, sul fondo di sabbia e di fango, sotto lo specchio d’acqua ove continuano a pullulare la nafta e l’aria, il Jalea morto giace coi suoi morti. Un d′essi è scivolato fuori dalla falla di poppa, e va fluttuando nella striscia oleosa.
Dove sono i tre nuotatori che mostravano di aver tanta fretta? Dov′è Biagio di Tullio? dov′è Guido Cavalieri? Hanno raggiunto la costa? hanno preso terra a Grado? già in salvo? Un materasso di gomma galleggia trasportato dalla marea, là, verso il Banco d′Orio. Vietri, che vuol dire costanza, mentre fa il morto, supino su l′onda squamosa, considera pacatamente le probabilità di salvezza e delibera. Sa che alla Mula di Muggia in quell’ora non c’è anima viva e che, se riescisse ad approdarvi, si troverebbe tutta la notte abbandonato in una spiaggia perfida di rena e di melma. A progredire verso Grado la corrente non gli è favorevole, anzi lo respinge al largo per levante. Ma quella stessa corrente, s’egli la segua invece di contrariarla, lo aiuterà forse a ridiscendere verso Grado nella prima luce del mattino. Gli conviene dunque riallontanarsi dalla terra e prepararsi a passare in mare una notte di circa nove ore. Non esita, non si scoraggia, non dubita delle sue forze, non ha paura dell’ignoto, non è stanco di lottare e di patire. « O cuore, sopporta. » Ed è un cuore di vent’anni!
Riconosce il proiettore austriaco di Duino; e su quello si regola per determinare via via la direzione e la velocità della deriva. Tutta la notte vede balenare, ode tuonare la battaglia lontana su l′Isonzo affocato. Il cuore non gli vien mai meno, né la mente gli s’offusca. È duro, costante, vigile, sagace. Come non si lascia sopraffare dall’ansia, così non si lascia vincere dal freddo, dalla sete, dalla fame. Sono passate quattro ore, e la notte è al colmo. Fra quattro ore comincerà ad albeggiare. La sua pazienza d’uomo supera la pazienza della notte. Il vecchio marinaio d’Itaca non è più virtuoso di questo imberbe marinaio campano.
Il sale lo impregna e lo preserva. Le stelle gli sono fauste. Alla diana egli scorge di nuovo la terra, avvista la riva di Grado. Allora getta il suo primo grido, il saluto del risveglio, il richiamo del gallo. Chiara è la voce, e aumenta con la luce. È la novissima giovinezza d′Italia che saluta il giorno, temprata nel suo mare. S’ode la voce su la spiaggia latina, nel vecchio porto dei Patriarchi, nelle acque gradate. Allora la sorte a tante prove così crude aggiunge un’ultima prova, la più cruda. Alla voce di soccorso ripetuta, escono senza indugio un battello a elica e una piccola barca lagunare, un topo da pesca; e si mettono alla ricerca del naufrago. Ma il capo cannoniere che guida il battello, quando è sul punto di scoprire il nuotatore, scorge un velivolo austriaco che traversa il golfo da Trieste volando verso Grado. Il rombo del motore impedisce di riudire la voce sottovento.
Egli tralascia la ricerca e ritorna nel porto, sotto la minaccia del nemico aereo. Il naufrago distante lo vede coi suoi occhi scomparire. Dopo la sedicesima ora di resistenza inumana, quando pare che il suo patimento sia per finire, ecco che egli deve chiedere al suo cuore un nuovo sforzo, il più difficile! Resiste anche alla disperazione. Aspetta che il velivolo passi, che il rombo si dilegui; e ricomincia il suo clamore. Il battello esce di nuovo; fa rotta ad ostro, verso l′origine della voce; avvista finalmente l′uomo, in vicinanza del gavitello che è posto al largo. Il capo cannoniere s′alza in piedi e grida di lontano al nuotatore: « Viva l′Italia!».
Vietri, che vuol dire ardore, si leva con tutto il petto fuori dell′acqua e risponde con tutta la possa dei suoi polmoni: « Viva l′Italia! ». Quando il battello gli è vicino, egli lo raggiunge con due bracciate; poi, senz’aiuto, pontando le braccia, sale a bordo. Respira; sorride; chiede da bere. Gli uomini del battello sono confusi: non hanno portato né acqua né cordiale. Uno gli offre una sigaretta, peritoso. Egli franco la prende, l′accende, tira qualche boccata di fumo, con gli occhi socchiusi, con un′aria di contentezza infantile, come se riassaporasse la vita di bordo, come se ritrovasse il primo tra i piaceri del marinaio.
Sbarcato, condotto all’infermeria, non perde mai le forze, non si lascia mai vincere dal malessere e dalla stanchezza. Conserva la sua disciplina in ogni atto, in ogni motto, come – dopo sedici ore di mare – la sua pelle serba il buon colore di frumento e la ferma grana, conciata all’uso nostro, all’uso d’Italia, non con la vallonea spenta nell’acqua di mortella, ma col sale e col sole. Quando nomina la sua nave perduta, quando parla del suo comandante e dei suoi compagni rimasti nel fondo sepolti, quando apprende che nessuno è giunto in salvo, di quelli esciti con lui dal portello di prua, il dolore lo stringe: un dolore senza lacrime, un dolore d’eroe, che par gli intagli quel dolce volto con uno scalpello più severo. Resta mutolo e fisso, col capo reclinato. L’acqua salsa gli cola dall’orecchio giù per l’omero nudo.”
Il Comandante Giovannini era stato decorato, alla memoria, di una medaglia d’argento al Valor Militare.“
Anche al sottocapo torpediniere Vietri il Re Vittorio Emanuele III, con motu proprio concesse , con decreto del 7 novembre 1915, la Medaglia d’Argento al Valor Militare con la seguente motivazione:
“Per il coraggio contenuto in occasione della perdita del sommergibile su cui era imbarcato, prestando soccorso ad altri naufraghi e conservando sempre calma, fermezza e coraggio, finché dopo aver nuotato per oltre 16 ore riuscì finalmente a salvarsi sulla costa nazionale, mentre gli sarebbe riuscito assai più facile raggiungere la costa nemica, ciò che non volle per non essere fatto prigioniero”.
Ritornato alla vita civile aveva sposato la nota artista teatrale Luisella VIVIANI, sorella del più noto Raffaele. Si era dedicato all’attività artistica della moglie ed era divenuto impresario teatrale e gestore tra gli altri, del teatro Umberto di Avellino. Il ricordo del sommergibile “JALEA era rimasto così profondamente impresso nell’amina di Vietri che impose il suo nome alla propria figliola, tramandando così , nel tempo il nome del suo battello. Cosa avrà provato il cuore del vecchio Vietri, ogni volta che chiamava per nome la sua figliola!
Arturo Vietri morì a Napoli l’8 novembre 1955.
Trentanove anni dopo, veniva recuperato lo scafo e con esso i resti dei dodici marinai rimasti intrappolati sul fondo del mare. Di quel recupero resta testimonianza in due brevi filmati conservati dall’Istituto Luce.
Già nel 1953 il relitto si trovava in acque italiane ormai da tempo. A occuparsene fu un uomo di grandi capacità tecniche, ma anche spessore morale, il capitano Elvino Meriggioli, esperto in recuperi navali. Il relitto sarebbe dovuto finire in bacino a Trieste, ancora però in mano al governo alleato e in preda a fortissime tensioni.
La zona A di Trieste viveva gli ultimi momenti di negata italianità e, l’idea di svolgere in quella città martire le onoranze ai caduti dello “Jalea”, sembrava una legittima aspirazione, ma era piovuto inflessibile il divieto dell’autorità militare inglese del governo provvisorio.
Se ne registrarono i malumori italiani anche nell’aula di Montecitorio: “Il generale inglese carceriere di Trieste vieta onori militari ai morti del sommergibile “Jalea”, periti nell’esercizio del loro dovere combattendo a fianco degli inglesi nella grande guerra 1915-18 per la cosiddetta libertà di Europa e riemersi alla luce del sole proprio ora, per fatale volontà del destino che si leva per ammonimento e vergogna agli uomini”.
Per evitare di accendere la miccia in quella che era una vera e propria polveriera i resti dello “Jalea” vennero dirottati a Monfalcone, dove, nel bacino galleggiante del cantiere navale, l’8 maggio del 1954 iniziarono le operazioni di disinnesco dei siluri, apertura dei varchi d’accesso e recupero delle salme. Il 24 maggio 1954 i tronconi del sommergibile vennero portati a terra per la successiva demolizione, mentre il 6 giugno 1954 il duomo di Sant’Ambrogio fu teatro delle solenni onoranze funebri.
Nella cripta dedicata alla terza Armata nella parte bassa della chiesa di Sant’Ambrogio a Monfalcone, le dodici cassettine con i resti dell’equipaggio dello “Jalea”, ricoperte del tricolore della Marina, erano state allineate ed esposte ininterrottamente per 24 ore all’omaggio commosso di una folla immensa di cittadini, reduci e patrioti giuliano-dalmati.
Trasferite in chiesa e collocate su di un solenne catafalco, ricoperto da un drappo azzurro, che si stagliava sullo sfondo dell’altare maggiore, erano contornate da una siepe di più di cento bandiere, con i gonfaloni di Trieste, Gorizia, Grado, Monfalcone e Ronchi dei Legionari, ed i vessilli di tutte le città istriane.
A lato del presbiterio i numerosi familiari dei caduti e, altero e solenne, l’unico superstite dello “Jalea”, Arturo VIETRI, con sul petto appuntata la Medaglia d’Argento al Valor Militare e col cuore e la mente al ricordo dei naufraghi inghiottiti dal mare la sera del 17 agosto 1915.
Sul feretro del Comandante Giovannini, la Medaglia d’Oro al Valore Militare Spartaco SCHERGAT, il sommozzatore che aveva affondato ad Alessandria d’Egitto la “Queen Elizabeth”, aveva orgogliosamente deposto, dopo averla trionfalmente sventolata, la bandiera con il nastro dell’Associazione combattenti di Capodistria, portata a Monfalcone nascosta sotto le vesti di una giovane profuga.
Nel bacino di Ponzano, lo scafo dello “Jalea” era stato intanto demolito e niente più restava di questo glorioso sommergibile della prima guerra mondiale, solo piccoli cimeli si erano salvati: una parte della catena, la testata di un siluro e la targhetta bronzea delle officine Fiat-San Giorgio di La Spezia
Nel Sacrario di Redipuglia, al 22° scalone, i resti sono stati tumulati e finalmente anch’essi ricongiunti al compagno d’arme Giuseppe Martignoni, ogni sera le campane della Cappella diffondono nell’aere cento chiari rintocchi che, all’unisono con i centomila, rinnovano il sacrificio e il perenne giuramento all’Italia. PRESENTE.
«Ogni rintocco susciti un ricordo» «ogni ricordo susciti una preghiera»
All’ingresso del parco della Rimembranza a Monfalcone, nel 2012, è stato eretto un cippo, che ricorda l’Equipaggio e i Prodi che si sono adoperati per il suo recupero.
[1] Dal Forum di “Cimeetrincee” –La tragedia del r.s. JALEA
[2] Da un art. di Franco Marchiori “L’affondamento del regio sommergibile JALEA il 17 agosto 1915